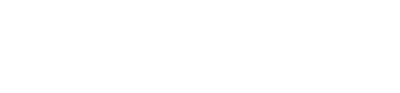Intervista con Alessandro Caranci, responsabile Satellite Communications di Telespazio
(A cura di Christian Cinetto)
“Telespazio è stato il primo service provider del satellite del mondo, abbiamo cominciato la nostra attività nel 1961, quando ancora i satelliti non erano in orbita. L’Italia si preparò a partecipare alla corsa verso lo spazio, e un gruppo di ingegneri fondarono quello che oggi è il centro spaziale del Fucino. Attualmente è il centro spaziale più grande del mondo per usi civili.”
La sede direzionale di Telespazio, a Roma, è come uno se la immagina. Vigilanza molto scrupolosa, il primo di molti modelli di razzo già all’ingresso e poi corridoi labirintici in cui l’ospite, se abbandonato, potrebbe ritrovarsi a essere il nuovo Frank Dixon di The Terminal.
Ogni tanto spunta qualche porta aperta con open space che somigliano a quelli della Nasa: monitor, monitor e ancora monitor. E ovviamente ingegneri, fisici, matematici e chissà quali e quante altre competenze sono racchiuse in un luogo che ospita centinaia di professionisti che si occupano di tecnologie all’avanguardia. Lo spazio, insieme ai fondali oceanici, è la frontiera della nostra conoscenza.
Il virgolettato appartiene all’ingegner Alessandro Caranci, Senior Vice President Satellite Communications di Telespazio, con cui ho avuto il piacere di conversare.
Partiamo dal principio: chi è Alessandro Caranci e come è arrivato a Telespazio?
Professionalmente sono un ingegnere, all’inizio della mia carriera mi sono occupato di cavi, poi ho iniziato a lavorare per Telespazio nel 2004. A un certo punto sono andato a lavorare in Eutelsat e poi sono tornato in Telespazio dove sono felicemente da più di 10 anni. Oggi guido la parte di satellite communication di questo gruppo, che nel mondo dello spazio è estremamente rilevante.
Il tuo percorso formativo è interessante: liceo classico e poi ingegneria, con una significativa parentesi sportiva.
Sì, nella mia parte adolescenziale c’era il rugby come primo obiettivo. Poi bisognava laurearsi e quindi ho cercato di arrivare a farlo, cosa che sono riuscito a fare. La mia passione del periodo giovanile è stata sicuramente il rugby.(Ndr: Caranci ha giocato in serie A e può vantare, tra l’altro, alcune presenze nella nazionale italiana).
Come concili questa formazione umanistica e sportiva con un settore così tecnologico? Il rugby è fortemente legato al campo, alla terra e tu ti occupi di spazio.
Credo che le società funzionino quando sono fatte da gente diversa. All’interno della mia azienda, non sono uno troppo affascinato dalla tecnologia. E questo mi permette di capire meglio gli utenti, i clienti, perché quando dai un servizio, non tutti vogliono capire come funziona, vogliono che funzioni. Il mio non completo interesse verso l’aspetto tecnologico ha fatto incrementare l’attenzione verso la customer satisfaction, elemento fondante di una società che funziona. Oggi con i sistemi a orbita bassa si parla molto di più di satelliti. Prima dovevo spiegare cosa fossero le comunicazioni satellitari, come quando giocavo a rugby e mi chiedevano se fosse lo sport con l’armatura. Oramai tutti conoscono il rugby e tutti sanno cosa sono i satelliti. Le tecnologie satellitari offrono prestazioni sempre più vicine al mass market, ma restano fondamentali per chi ha bisogno di comunicazioni sicure e affidabili ovunque si trovi. Noi ci concentriamo su segmenti di mercato specifici dove la nostra esperienza ci permette di garantire un servizio di qualità.
Senza citare nomi specifici, quali tipologie di clienti servite e con quali servizi?
I nostri clienti sono quelli che hanno un grosso costo se le comunicazioni non funzionano: il mondo governativo e militare e, nel mondo civile, quello dell’energia, della mobility, il mondo marittimo commerciale. Dal punto di vista teorico oggi possiamo garantire connettività ovunque. Il nostro valore sta nell’orchestrare soluzioni multiple che funzionano anche quando una componente fallisce. Per clienti che non possono permettersi di perdere il segnale, combiniamo tecnologie diverse ottimizzando costi, sicurezza, latenza e disponibilità per offrire l’unico elemento che conta davvero: la qualità percepita dal cliente. Oggi stiamo cercando di entrare nel settore dell’advanced air mobility: droni autopilotati, velivoli a decollo verticale, elicotteri con o senza pilota. Quindi immaginiamo una civiltà in cui a un certo punto i pacchi arriveranno con un drone, il sangue viene portato negli ospedali attraverso degli elicotteri e magari invece di uscire di casa saliamo sul terrazzo, prendiamo il nostro aereo a decollo verticale e ci spostiamo da un’altra parte. Ora, tante cose che sembravano fantascienza, poi diventano scienza e infine diventano cose normali. Quello che sicuramente lega tutti questi oggetti è che dovranno essere collegati attraverso un sistema di comunicazione. E non è detto che le comunicazioni terrestri siano in grado di poter raggiungere sempre questi oggetti o che siano sempre disponibili, perché una delle caratteristiche della tecnologia satellitare è quella che può essere fornita ovunque e quindi può essere quell’ombrello di garanzia che permette a un oggetto di trovare sempre un modo di comunicare con il resto del mondo. Per noi questo è un segmento di grande prospettiva.
All’inizio hai citato il Fucino, simbolo della storia spaziale italiana. Cosa rappresenta oggi?
Il Fucino è una storia di successo. Oggi ospita centri di controllo estremamente importanti, come quello della costellazione Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo all’avanguardia nel mondo. Il Fucino è un’infrastruttura critica nazionale e in prospettiva, sarà anche il centro che ospiterà uno dei centri di controllo della costellazione IRIS², la nuova costellazione della comunità europea per gestire le comunicazioni sovrane, un sistema che permetterà agli europei di comunicare in sicurezza con oggetti, sistemi, player, all’interno della comunità europea stessa.
La presenza di nuovi player nell’orbita bassa, come Starlink, ha cambiato il mercato. Come vi siete adattati?
Noi cerchiamo di utilizzare tutto quello che è disponibile. Con Starlink abbiamo un accordo di distribuzione. Starlink ha caratteristiche positive: una latenza ridotta, perché sono satelliti a 500 km di orbita contro i 36.000 km delle orbite geostazionarie, e un costo per bit competitivo.
Mi piace raccontare quello che facciamo come se fossimo un ristorante. È arrivato un nuovo ingrediente, il tartufo, e noi lo mettiamo nelle pietanze, magari accanto a una parte geostazionaria o a una rete terrestre. Il nostro mestiere è mettere insieme più componenti per dare il miglior servizio possibile. Starlink ha conquistato 4,5 milioni di utenti grazie alla latenza ridotta e al costo competitivo. Il mercato vedrà presto altri player come OneWeb e Kuiper di Amazon, e per noi più ingredienti significano pietanze migliori. Il nostro valore è combinare gli ingredienti conoscendo i gusti dei clienti, come dei veri “metaoperatori”: operatori che non possiedono i satelliti.
C’è il rischio che questa popolarità improvvisa faccia sì che alcuni vostri clienti si rivolgano direttamente a queste nuove soluzioni più economiche?
C’è un rischio di “commoditizzazione” della connettività. Per questo ci siamo focalizzati su quei clienti che non cercano la commodity. Mentre il ferramenta può comprarsi uno Starlink, chi ha bisogno di connettività sempre, magari pagando penali enormi in caso di disservizio, continua a preferire un’azienda con 60 anni di esperienza. In alcuni casi si possono perdere delle vite umane, perché a volte le nostre comunicazioni sono a supporto di missioni importanti. Qui dentro respiriamo la cultura del servizio. Veniamo dal mondo della televisione, un mondo di efficacia: accendevi la TV e funzionava. E se non funzionava era il tuo televisore a non funzionare, ma il segnale arrivava sempre. Ancora adesso ce ne occupiamo, forniamo il servizio a Rai, Sky, Mediaset e altri.
State lavorando anche alla comunicazione interplanetaria, come il progetto Moonlight per la Luna.
Moonlight è un programma della comunità europea e dell’ESA che vede Telespazio come capofila e prevede un sistema di telecomunicazione e posizionamento sulla Luna. È un argomento affascinante, che richiede di essere visionari ma anche concreti. Telespazio ha sempre avuto questo modo di essere: ha portato la televisione in Italia quando non c’era, ha realizzato i primi collegamenti punto a punto tra Stati Uniti ed Europa.
Nel futuro, nei prossimi 10-20 anni, è possibile che tutte le nostre comunicazioni avvengano solo grazie ai satelliti?
È sbagliato pensare che la soluzione non sia in un mix di tecnologie. Ci sarà sempre una coesistenza tra fibra, comunicazione mobile e comunicazioni satellitari. Se prendiamo l’Italia come esempio, tutti vorrebbero essere connessi. Ma come realizzare questa connettività universale? Analizzando la densità di popolazione, vediamo che la fibra ha costi diversi per utente: portarla in un palazzo con 50 famiglie è efficiente, mentre in una villetta isolata lo stesso investimento servirebbe un solo cliente. Per questo le architetture di connettività dovrebbero basarsi su tecnologie diverse e complementari. In futuro, fibra, reti mobili e comunicazioni satellitari coesisteranno. Le comunicazioni satellitari stanno riducendo drasticamente il loro costo per bit, diventando sempre più competitive. Parallelamente, stanno emergendo costellazioni per il Direct to Device, che permetteranno ai normali telefonini di connettersi direttamente ai satelliti. L’utente non saprà se è collegato via satellite o rete terrestre: avrà semplicemente il suo servizio. Questo porterà a un sistema di gestione unificato che indirizzerà i dispositivi verso celle terrestri o satellitari in modo “seamless”. Ci sono ancora passaggi da compiere, ma l’industria sta procedendo in questa direzione più velocemente di quanto potessimo immaginare.
Come vedi l’evoluzione delle tecnologie satellitari nei prossimi anni?
Le tecnologie stanno evolvendo rapidamente. Si utilizzano frequenze sempre più alte e si sviluppano link di tipo ottico. Noi stiamo lavorando su due fronti: le comunicazioni ottiche e le chiavi quantistiche per la protezione della sicurezza. Ci sono aspetti che devono maturare e costi che si devono abbattere, ma saranno elementi di novità molto importanti.
C’è un aneddoto che ti è rimasto impresso in questi anni di lavoro?
Mi ricordo un’iniziativa di tanti anni fa. Davamo la connessione a una famiglia che, per una malattia rara del figlio, era obbligata a vivere in mare. Questo ragazzo viveva su una barca a vela e seguiva le lezioni attraverso sistemi di formazione a distanza che noi fornivamo. Il satellite è l’elemento più democratico che esista. Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in Iraq abbiamo fornito a una serie di ospedali la possibilità di avere una seconda opinion dall’Italia, necessario per lo screen di una serie di malattie.
Telespazio è una società italiana di altissima tecnologia. Sei fiducioso che possa continuare a prosperare in un mercato globale sempre più competitivo?
Io credo assolutamente di sì. In Italia c’è un elevato interesse per lo spazio, è una tradizione di cui andiamo fieri, e in questo momento si sta investendo molto. Sono decisamente ottimista. L’industria spaziale italiana è riconosciuta come un elemento d’eccellenza a livello globale: i conti vanno bene e sempre più persone lavorano in questo settore, non solo in Telespazio ma anche in altre società. L’Italia ha una sua collocazione che deve mantenere. Certo, altri Paesi possono avere più fondi o sviluppare tecnologie diverse, ma continueremo a dire la nostra con lo stile italiano di approccio allo spazio. E non siamo solo italiani: abbiamo la fortuna di essere un gruppo transnazionale con diverse culture. Qui puoi parlare con tedeschi, brasiliani, francesi. Gli scambi sono frequenti e ci permettono di capire che possiamo essere un’eccellenza proprio perché siamo diversi, con prospettive uniche. Ognuno ha la sua cultura e se riusciamo a valorizzare quella italiana in questo segmento, possiamo continuare a fare la differenza.